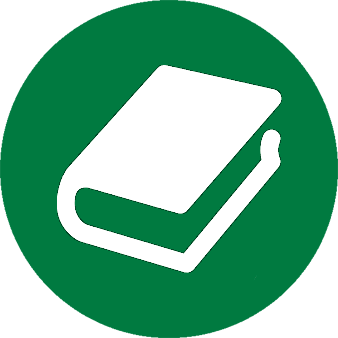È difficile pensare che un semplice bicchiere di latte possa raccontare una storia millenaria, ma è proprio così. La capacità di digerire il lattosio – lo zucchero del latte – non è qualcosa di scontato: è frutto di un’evoluzione genetica, di una mutazione specifica, comparsa in alcune popolazioni circa 7.500 anni fa.
Prima di allora, nessun essere umano adulto produceva lattasi, l’enzima necessario a digerire il lattosio. Dopo lo svezzamento, la produzione calava drasticamente, perché il latte non faceva parte della dieta dell’adulto. Ma con l’avvento dell’agricoltura e soprattutto della pastorizia, qualcosa cambiò.
Alcuni gruppi umani iniziarono a consumare latte anche in età adulta. E in questi gruppi comparve una mutazione, localizzata nel gene regolatore MCM6, che permetteva al gene LCT di continuare a esprimere l’enzima lattasi anche dopo l’infanzia. In altre parole: nacque la persistenza della lattasi.
Una mutazione utile, selezionata dall’ambiente e dalla cultura. Un adattamento genetico che oggi determina chi può digerire il lattosio… e chi no.
Questa mutazione – nota come variante –13910*T (rs4988235) – è stata identificata come la principale responsabile della persistenza della lattasi nelle popolazioni europee. Secondo importanti studi genetici, come quello di Bersaglieri et al. (2004, American Journal of Human Genetics), la sua diffusione risale a circa 7.500 anni fa, durante la transizione al neolitico e lo sviluppo della cultura della ceramica lineare in Europa centrale.
Chi eredita la variante CC del gene MCM6 tende a perdere precocemente l’attività lattasica, mentre chi ha la variante TT riesce a digerire il latte anche da adulto.
Ma oggi, che senso ha conoscere questa mutazione? È solo curiosità evolutiva? O ha un valore clinico reale?
La risposta è chiara: ha un impatto concreto sulla salute di milioni di persone. L’intolleranza al lattosio è una delle cause più comuni di disturbi intestinali cronici, ma anche di sintomi meno ovvi: emicranie, dermatiti, stanchezza persistente, reflusso, anemia.
Spesso, però, non viene diagnosticata. I test del respiro possono dare falsi negativi o positivi incerti. I sintomi sono aspecifici. E così, migliaia di persone continuano a soffrire senza sapere il perché.
Il test genetico, in questo contesto, è uno strumento prezioso: non cambia al mutare della dieta o dell’età, è definitivo, e consente di fare prevenzione prima che i sintomi si cronicizzino.
Identificare precocemente una non-persistenza lattasica permette di evitare problematiche come:
- colon irritabile e disbiosi intestinale
- osteopenia da scarso assorbimento di calcio
- malassorbimento di ferro e vitamina D
- gonfiore, crampi, meteorismo e diarrea post-prandiale
Il latte non è un nemico, ma può diventarlo per chi non è geneticamente predisposto a digerirlo.
Nel Metodo BMS, il dato genetico viene sempre inserito in una visione olistica: non si tratta solo di eliminare un alimento, ma di costruire una nuova armonia alimentare su misura.
Nei centri BMS, grazie all’impiego di impedenziometri professionali di altissima precisione, è possibile monitorare la massa ossea e la massa minerale corporea nel tempo. Questo permette di valutare in modo oggettivo l’impatto che una dieta più adatta può avere sul metabolismo osseo, soprattutto nei soggetti che hanno consumato per anni alimenti contenenti lattosio senza saperlo e hanno sviluppato malassorbimenti cronici.
Per chi è intollerante, il piano include:
- eliminazione del lattosio
- introduzione di alimenti naturalmente ricchi di calcio e vitamina K2
- probiotici mirati per migliorare l’ecosistema intestinale danneggiato
- integrazione nutraceutica con enzimi lattasi disponibili in commercio, al bisogno
- valutazione sistematica dell'analisi impedenziometrica
Esistono alternative sicure: yogurt senza lattosio, bevande vegetali arricchite, cibi fermentati compatibili. Ma soprattutto esiste un nuovo modo di pensare la nutrizione, non più per esclusione ma per costruzione funzionale.
Parlare di intolleranza al lattosio oggi significa raccontare una storia di adattamento, di genetica, ma anche di ascolto del proprio corpo.
Nel Metodo BMS ogni dato genetico è un tassello. Ma è la lettura integrata – tra sintomi, storia personale e visione clinica – che fa davvero la differenza. Perché non basta sapere di avere una mutazione: serve capire come questa influenza la propria vita, e come accompagnarla verso il benessere. La consapevolezza è la chiave centrale nella logica BMS.
Il cambiamento inizia anche da qui. Da un test. Da un bicchiere di latte. E da una visione più ampia della salute.